Storia di nonna Fina e di sua figlia Giovanna
di Ivana Tonini
(introduzione) Il 23 agosto 2023 è mancata Ivana Tonini. Nata il 13 marzo 1945, a guerra in corso, castellana di origine, viveva da molto tempo a Bologna. Io l’avevo conosciuta nel 2012, quando preparavo il volume sulle donne partigiane, e cercavo notizie di Giovanna Mingazzini, madre di Ivana, una delle castellane che aveva fatto la staffetta fra il 1944 e il 1945. Mi ero rivolto a Matteo Tonini, libraio a Ravenna ma castellano doc, cugino di Ivana, che mi diede il suo recapito.
Incontrai Ivana in piazza Galvani a Bologna, e parlammo seduti sulle panchine poste ai piedi del monumento all’illustre fisico. Mi raccontò alcune cose, e io le spiegai il progetto del libro. Era mia intenzione intervistarla per scrivere la storia di sua mamma, ma lei, non so perché, aveva capito che le chiedevo di scrivere direttamente lei la storia.
Ci mise un impegno incredibile (questo lo seppi dopo, dalla sua storica amica Mig Brandinelli), perché, a causa dei gravi problemi di salute che l’avevano tormentata sin da ragazza, a seguito di un ennesimo malore aveva perso completamente la capacità di leggere e di scrivere (lei che era una stimata insegnante a Bologna) e quando l’avevo incontrata si stava riprendendo e stava imparando nuovamente daccapo.
Scrisse un pezzo molto bello, dedicato a sua madre Giovanna Mingazzini, a sua nonna Fina e parlò di suo padre, pur egli partigiano, Francesco Tonini (Chicò d’Vegna). Voleva rendere loro un pizzico di giustizia e con tanta determinazione si mise a scrivere il bellissimo pezzo che qui di seguito riproponiamo, già pubblicato sul volume “Non ho poi fatto tanto”.
Ivana Tonini venne alla presentazione, al circolo ARCI, nell’autunno del 2013, e rivide alcune sue storiche amiche d’infanzia. Fu quella sera che Mig Brandinelli, che l’aveva accompagnata, mi rivelò che la preparazione dello scritto aveva consentito ad Ivana di riprendersi notevolmente dal malore che aveva subito, e mi aveva ringraziato. Io le dissi che alla base di tutto c’era stato un fraintendimento, ma che forse tutto questo non era avvenuto così per caso, e che ero contentissimo del doppio successo che la mia iniziativa aveva avuto.
Ora sulla tomba di Giovanna e Francesco c’è anche il ricordo di Ivana. Era una donna molto bella, al punto, come ricordava lei stessa sorridendo, che quando era una ragazzina i comunisti castellani, irriverenti, avevano organizzato una sorta di processione civile e avevano issato lei su un carretto, a mo’ di Madonna. Ivana mi disse che conservava anche una foto di quella goliardata, assieme ad altri documenti castellani. Mi aveva promesso di farmeli consultare, ma poi la salute peggiorò nuovamente e purtroppo non ho avuto più il piacere di rivederla. La ricordo con affetto e con nostalgia, nonostante l’abbia vista 4 o 5 volte in tutto, e penso che il modo migliore di omaggiarla sia ricordarla assieme ai suoi genitori e a sua nonna Fina. (A.S., 11 novembre 2023).
Premessa
Quando, alcuni mesi fa, lo storico Andrea Soglia mi chiese di scrivere i miei ricordi sull’ impatto che le guerre mondiali avevano prodotto sulla mia famiglia, in particolare sulle donne, fui molto contenta di poter rendere un pizzico di giustizia a tanto coraggio, tanta volontà e tanta sofferenza. Purtroppo i protagonisti di questi ricordi se ne sono andati per sempre quando io ero ancora giovane e non mi ero data nessun compito di rendere sistematiche le loro memorie. Perciò quello che resta nel mio ricordo è solamente un insieme di episodi singoli, racconti occasionali, considerazioni del tipo di quelle che si sentono in famiglia, gli “amarcord” di coloro che, pur essendo stati protagonisti, hanno sempre pensato, come diceva mio padre, di avere fatto soltanto “quello che c’era da fare”.
Storia di nonna Fina e di sua figlia Giovanna
In Romagna, nel Novecento e soprattutto nella prima metà del secolo, molte persone venivano chiamate con un nome diverso da quello registrato all’anagrafe: poteva trattarsi di un diminutivo o di un’abbreviazione e, comunque, il risultato era una fantasiosa distorsione dell’originale.
Mia nonna si chiamava Giuseppina, in dialetto Jusfena, abbreviato Fena e italianizzato Fina.
Le vecchie foto dell’epoca ci consegnano ancora l’immagine placida e composta di una ragazza bruna e un po’ robusta, dal viso sereno e severo, con grandi e profondi occhi scuri.
Ancora giovanissima si innamorò, ricambiata, di Sante, un ragazzo biondo ed esile che, per una lontana parentela, portava il suo stesso cognome, Mingazzini.
Entrambi provenivano da famiglie contadine, con qualche appezzamento di terra in proprietà, frutto di secoli di durissimo lavoro nelle campagne di ricchi possidenti. Erano abituati a fatiche molto dure, lei nei campi e nei lavori domestici, compreso la cura degli animali da cortile, mentre lui lavorava la sua terra e andava saltuariamente a prestare la sua opera presso il vicino convento di Santa Chiara.
La bruna e vivace ragazza e il biondo giovanotto dai baffetti sottili si sposarono ben presto ed ebbero una bimba, Giovanna, somigliante al padre, con grandi occhi grigi e capelli dorati.
Era piccolissima quando scoppiò la grande guerra e il suo giovane padre fu costretto a partire per il fronte.
Alcuni mesi più tardi, durante una qualunque mattinata di lavoro, Fina fu raggiunta dal postino mentre si trovava da sola nei campi. Dal tipo di lettera che le venne consegnata, la giovane, pur non sapendo leggete, capì: di buste come quella ne aveva già viste altre al paese. Fu costretta a sedersi su una zolla, impietrita dal dolore e dalla paura e così la trovarono due parenti di passaggio alcune ore dopo, mentre continuava a fissare, con gli occhi asciutti, una zona vuota.
I giorni che seguirono non sarebbero andati a far parte dei suoi ricordi e dei suoi racconti. Il pudore dei sentimenti, i bisogni materiali, la bambina così piccola la spinsero ad andare avanti. La morte del giovane marito aveva causato un vuoto importante non solo nel mondo dei suoi sentimenti, ma anche nella conduzione dei lavori agricoli. I parenti furono chiari sull’argomento: Fina poteva restare nella casa che l’aveva accolta il giorno delle nozze, ma avrebbe dovuto raddoppiare il suo impegno nei campi per sostituire chi non c’era più e, ovviamente, occuparsi dei lavori domestici e della bimba.
La giovane vedova di guerra -questa era ormai la sua categoria sociale di appartenenza- accettò.
Del resto non avrebbe potuto fare diversamente poiché quello era il posto che spettava a sua figlia. Però il lavoro era durissimo e il tempo da dedicare alla piccola veramente poco. A questo punto accadde l’imprevisto: dal convento di Santa Chiara giunse un invito. Le suore, grate al giovane Sante che prima aveva lavorato per il Convento, poi era stato chiamato a morire per la patria, si dichiararono disponibili ad accogliere sua figlia come educanda. Fina fu di nuovo travolta da sentimenti dolorosi e contrastanti, ma, alla fine, sull’attaccamento e la tenerezza materni prevalsero la stanchezza e la convinzione che quel luogo, deputato dalle migliori famiglie all’educazione delle figlie , poteva essere veramente una fortuna per la piccola che, così, fu mandata in collegio.
Tutto sommato, se la cavò. Dai suoi racconti e dai suoi silenzi mi fu possibile immaginare una vita interiore non lineare, piena di sentimenti contrastanti, gratitudine e insofferenza, voglia di amicizia e chiusura, desiderio di comunicare e angosciante timidezza. Durante l’estate poteva tornare nella sua famiglia che, eccetto l’amatissima madre, le era sempre più estranea; poi, nei periodi scolastici eccola di nuovo in collegio dove imparò molte cose, l’italiano e la matematica, il latino e il francese, il disegno e il ricamo e perfino la ginnastica: l’educazione di queste fanciulle doveva davvero essere completa, anche se conseguire un diploma non era necessario.
Già adulta, quasi ventenne, Giovanna tornò a casa, cambiò di nuovo il contesto della sua esistenza e dovette imparare nuove regole e nuove mansioni, lavorare nei campi, lavare, cucire e far da mangiare per la numerosa famiglia. Mai, però, permise che il suo nome subisse alcuna modificazione. La mamma le stava vicino, finalmente con l’adorata figlia, ma senza essere capace di manifestarle il suo affetto: non faceva parte della cultura di quei luoghi e di quei tempi e in particolare della sua, che solamente per pochissimo tempo aveva conosciuto la tenerezza. Così anche la giovane, educata, tenera, istruita ragazza aveva fatto il suo ingresso nel duro mondo agricolo, tutto organizzato sui ritmi e sui tempi che andavano dalle semine ai raccolti.
Unico svago le passeggiate in paese nei giorni di festa, che avevano come scopo principale, come ovunque, quello di conoscere altri giovani. Fu così che incontrò Checco, ovviamente Francesco, che, quando la vide per la prima volta da lontano, senza neppure sapere chi fosse, comunicò agli amici: “Quella ragazza la sposo io”. Ciò avvenne dopo poco tempo.
L’ex collegiale, ben educata e timida si innamorò subito di quel giovane focoso e intrepido, che aveva lasciato presto gli studi per insofferenza verso un sistema che non tollerava e dal quale fu ricambiato e che si era distinto invece nell’esercito per il coraggio e la buona affermazione nelle attività sportive, in particolare nella novità del pugilato. A casa lavorava i campi con i genitori e il fratello Marco. Segretamente, però, aveva coltivato ben altri interessi.
In Italia imperversava il fascismo che aveva organizzato una società basata sul consenso obbligato. Questo consenso effettivamente ci fu e in parte fu autentico, ma in parte di comodo, simulato per ottenere o mantenere il lavoro, per non subire attacchi che potevano andare dall’olio di ricino al manganello, dal carcere al confino, in alcuni casi alla morte. Checco non era tipo da adattarsi a queste costrizioni ma in qualche modo riuscì sempre ad evitare rappresaglie e castighi. Segretamente leggeva libri che circolavano nonostante le proibizioni e così si avvicinò al marxismo di cui apprezzava fortemente la teoria dell’uguaglianza, del lavoro e della lotta di classe. Sognava una società libera e giusta, dove tutti avessero potuto dare il meglio di sé e nessuno avesse dovuto patire la fame, le ingiustizie e i soprusi. Odiava quella guerra in cui il fascismo si era impantanato al traino dei tedeschi.
Così, dopo l’ 8 settembre, fu subito nella Resistenza e Giovanna con lui.
Il territorio in cui Checco si impegnò fu quello delle colline sopra Riolo Terme, verso Casola ma talvolta anche verso e oltre Imola, nella direzione di Bologna, per i crinali e i sentieri in mezzo alla boscaglia. Conservo ancora, tra le cose che più mi sono care, una valigetta di legno che usava per trasportare farmaci d’urgenza da una postazione all’altra, dove erano necessari. Non furono solo umanitarie le azioni che mio padre dovette compiere in quella guerra. Purtroppo in ogni guerra esiste il lato più oscuro, più tragicamente violento che non si può evitare. Si può e si deve evitare la guerra, perché, dopo, è sempre troppo tardi. Me lo insegnò proprio mio padre una volta in cui io, giovanissima pacifista, quasi bambina, lo apostrofai con forza, chiedendogli se mai, durante la guerra, avesse ucciso qualcuno. Mi guardò con tanta tristezza e mi raccontò un episodio che gli era accaduto. Una volta, là nelle sue colline sopra Riolo, fu catturato di sorpresa da due tedeschi che, tenendolo sotto tiro, gli misero in mano una vanga e gli ordinarono di scavare una fossa. Fatti del genere ne erano già accaduti: Checco sapeva che la fossa era destinata proprio a lui. Allora, con un gesto fulmineo, con tutta la sua forza e la sua disperazione, fece roteare la vanga, colpì ed abbatté i tedeschi che chiacchieravano distratti e sicuri della loro superiorità, con lo strumento che gli avevano messo in mano. Mio padre concluse il tragico racconto chiedendomi: “Tu cosa avresti fatto?”. Tacqui. Avevo capito, in quel momento, con grande dolore e senso di impotenza, che, quando le guerre sono in corso, il pacifismo è certamente poco praticabile; l’unica, vera soluzione sta nel non farle iniziare mai.
Altri ricordi affollano la mia mente, ma sono ormai soltanto frammenti, suggestioni, immagini di una bambina che non ha mai chiesto nulla di più di ciò che i grandi raccontavano, perché quelle storie facevano paura. In particolare ricordo l’angoscia che mi pervase quando sentii che mio padre era stato condannato a morte in contumacia. Non conoscevo il significato del termine, ma abbinato al resto del discorso, che poi sarebbe stato appeso per il collo con un gancio ed esposto al pubblico, provocò in me uno stato d’animo il cui pensiero ancora mi turba.
E ancora ricordo il racconto di mio padre sull’ ultimo episodio, sulla conclusione della guerra in quella zona, quando il suo gruppo incontrò gli alleati che avanzavano verso Nord. Checco li esortò ad affrettarsi, ma loro, per tutta risposta, gli chiesero di garantire con la sua vita che il territorio fosse completamente libero dai tedeschi. Checco garantì, anche se ovviamente la certezza assoluta nessuno poteva averla. Così proseguirono e non ci furono ostacoli. Era fatta, ma in casa ci si interrogò a lungo su questo atteggiamento degli alleati. Perché non si affrettavano? Perché chiedevano garanzie? Vincere serviva a tutti, non solo ai partigiani. Vero è che doveva esserci un collegamento tra l’avanzata da Nord e quella da Sud, ma a quel punto alcune ore non sarebbero state determinanti. Cosa allora? Scaricare responsabilità, non fidarsi di nessuno? Anche questo appare improbabile. Resta sempre, comunque, l’errore di valutazione che molto offese, comprensibilmente, i nostri.
Giovanna, nel frattempo, cosa aveva fatto? Era rimasta sempre a fianco di Checco e nelle condizioni disperate in cui si trovavano, visse il suo amore di giovane sposa. Rimase incinta per la prima volta di un bimbo che non ce la fece, poi di me, nata poche settimane prima della fine del conflitto. Intanto cercava di aiutare come poteva i partigiani e, mi disse una volta, una donna incinta che camminava dimessa per strada non attirava l’attenzione dei nemici. In questo modo poteva muoversi per portare messaggi e, a volte, anche armi che, a suo dire, il pancione nascondeva bene.
Continuò a correre rischi, per se stessa e anche per me, sia pure involontariamente, anche dopo la mia nascita, avvenuta in una cantina adibita a rifugio, a Riolo. Ma sapeva che i rischi si correvano in ogni modo e che molti erano stati uccisi per caso, perché si trovavano nel posto sbagliato o per sospetto o per rappresaglia. Una volta, pochi giorni dopo la mia nascita, arrivarono nell’edificio alcuni soldati tedeschi e scesero nello scantinato dove mia madre era sdraiata accanto a me. Erano armati e minacciosi, ma l’ufficiale che li comandava li fermò e li fece allontanare. Poi si diresse verso di noi, appoggiò le armi lontano da sè e si sedette. Ci guardò a lungo e mi fece una carezza. Poi si rivolse a mia madre e le disse: “Nella mia famiglia non c’è più nessuno, tutti uccisi. Quando la guerra sarà finita, tornerò a prendervi e vi porterò con me”. Se ne andò rapidamente con i suoi soldati e nessuno lo rivide mai. Mia madre scoppiò in lacrime: aveva avuto tanta paura per me e per se stessa, ma anche tanta pena per quello che era sì un nemico pericoloso, ma anche un disperato che forse un tempo aveva creduto in quella guerra, ma che ormai sosteneva la sua esistenza aggrappandosi a vane suggestioni.
Nonna Fina, intanto, aveva trascorso tutto quel tempo come sempre, come durante la prima grande guerra, lavorando e cercando di procurare cibo per sé e per i suoi cari, quando aveva occasione di vederli. Ma questo conflitto non risparmiò proprio nessuno e in casa di Fina, la vedova di guerra, un giorno arrivò un gruppo di tedeschi e di fascisti che cercavano Checco e che volevano sapere da lei dove si trovasse. Per costringerla a parlare, prima la minacciarono, poi la picchiarono, sempre più violentemente e crudelmente, fino a ridurla a un essere irriconoscibile, coperto di sangue, con alcune vene spaccate, tumefatto fino a non essere più riconoscibile. Poi, in mezzo a quella situazione assassina si levò imperiosa la voce di uno di loro, un italiano: “Basta, lasciatela stare, è chiaro che non sa niente”. Così se ne andarono, abbandonandola a terra, dove fu trovata più tardi da alcuni vicini. Per tutto il resto dei suoi anni Fina ricordò con gratitudine l’uomo che, con disinvoltura, le aveva salvato la vita. “Era uno -diceva- che faceva il doppio gioco. Faceva finta di essere uno di loro, invece era dei nostri”. “E perchè, allora, non ti ha salvato prima e ha rischiato che ti ammazzassero?” Chiedevo io, bambina preoccupata, alla mia nonna .”Perché – mi rispondeva lei – se l’avesse fatto, avrebbe potuto destare sospetti nei fascisti”. Del resto questa persona, neppure dopo la fine della guerra, rivelò mai il suo nome e chiese a chi lo conosceva di rispettare la sua decisione: Fina la rispettò.








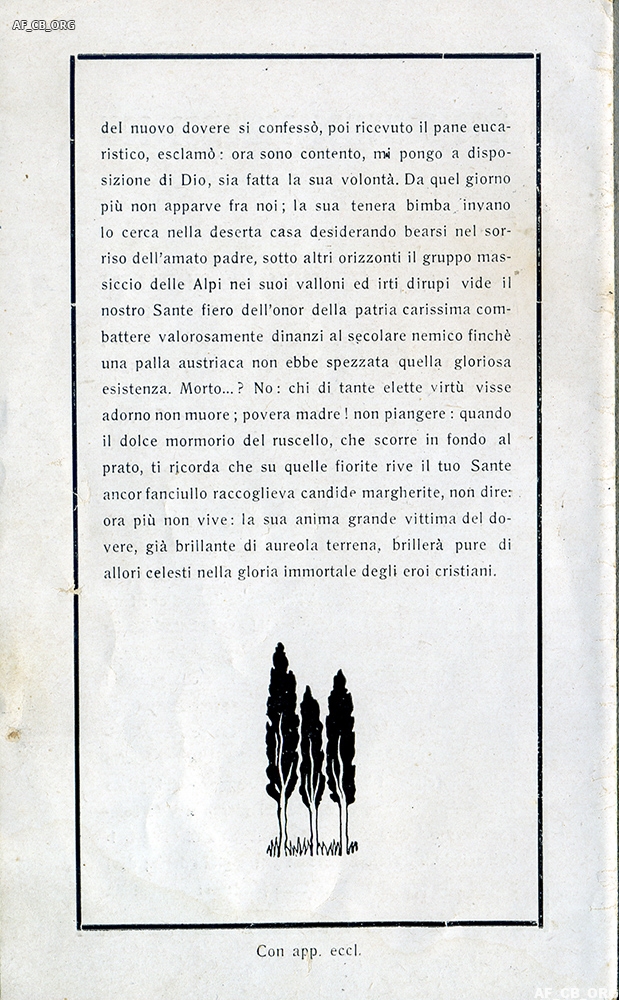



Lascia un commento